PENSIERI LIBERI
Don Maurizio Compiani Docente del corso di Intelligenze Artificiali e questioni etiche nella Laurea magistrale di Innovazione e Imprenditorialità digitale dell’Università Cattolica
Ottobre 2024


Agire in modo intelligente non significa essere intelligenti. La lavastoviglie di casa lava i piatti meglio di me. I suoi sensori individuano lo sporco e attivano i programmi più efficaci: calcolano la temperatura dell’acqua, dosano il detersivo e il brillantante, ottengono perfino un risparmio nel consumo dell’acqua contribuendo a un minore impatto sull’ambiente.
Nonostante ciò, la lavastoviglie non è intelligente. E tanto meno posso dire che sappia pensare. Anche se ricca di programmi, in fin dei conti la mia lavastoviglie non è più intelligente del mio rasoio elettrico: ha solo una potenza maggiore di calcolo applicata a dei sensori congeniali al compito che deve svolgere. Un tale chiarimento è utile quando si parla di Intelligenze Artificiali.
Non si tratta veramente di intelligenza, ma di macchine che agiscono in modo intelligente senza essere intelligenti. L’Intelligenza Artificiale non è più intelligente di un tostapane ma, come la lavastoviglie, agisce in modo intelligente ottenendo brillanti risultati ai compiti che le se sono richiesti, migliori di quelli che io potrei mai produrre, pur essendo intelligente. Come è possibile questo? La forza dell’IA è la sua velocità e potenza di calcolo. Da anni, in modo spesso impercettibile, stiamo adattando l’habitat e noi stessi che viviamo in esso, ad essere un luogo particolarmente favorevole al linguaggio degli algoritmi, fatto di calcoli e statistiche.
Sì, perché anche l’IA come la lavastoviglie a incasso, ha bisogno di uno spazio adatto in cui funzionare bene. Gli ingranaggi della lavastoviglie e i suoi programmi perderebbero di efficienza se non agissero entro quella scatola metallica che li contiene, fino a non funzionare più e ad allagare la cucina. In casa, in ufficio, per strada, attraverso touch screen, comandi vocali, dispositivi di ascolto, applicazioni sensibili ai gesti, dati di geolocalizzazione e tanto altro stiamo sempre più costruendo un mondo adatto all’IA in cui essa riesce a muoversi con sempre maggiore velocità. Tutto è sempre più monitorato: produciamo di continuo dati.
Proprio essi sono la scatola che permette all’IA di funzionare bene accelerando in calcoli sempre più accurati, ottenendo con successo risultati nei più svariati settori. E ciò senza per questo essere davvero intelligente. Ci ritroviamo a vivere avvolti da una crescente maglia di connessioni, a cui l’IA fornisce il suo linguaggio, quello digitale matematico, che mette in comunicazione tutte le tecnologie tra loro.
Il digitale ha offerto quella lingua universale cercata da secoli per realizzare la comunicazione ideale tra saperi differenti: dalla sanità all’economia, dall’educazione ai trasporti, dal settore bellico a quello ludico, le IA scompongono e ricompongono i dati mostrando correlazioni dove noi non potevamo vedere nulla. Grazie alla crescita sbalorditiva delle capacità di archiviazione ed elaborazione di continuo separano e tornano a ricomporre i dati in sequenze sempre più ampie, sempre più nuove.
Le IA non investigano le cause, rivelano continue correlazioni, creano mondi nuovi per poi archiviarli e crearne subito di nuovi. È in questa ‘realtà’, che ci troviamo: viviamo sempre più diffusamente onlife, sia digitalmente che analogicamente. Ed è una rivoluzione che influisce sul modo tradizionale di comprendere le cose. Termini per secoli basilari al sapere, forniti dalla filosofia tramontano o vengono ridefiniti in altre categorie: vero, reale, naturale, artificiale, essenza, spazio, tempo, uomo, persona, vengono riformulati alla luce di una metafisica dell’informazione e non più dell’essere. Le conseguenze sono molte. Da generatori del processo innovativo, gli esseri umani, o molti di essi, rischiano di ritrovarsi inavvertitamente solo parte del meccanismo: trattati come mezzi anziché come fini.
L’avvolgimento digitale infatti è una tendenza robusta, cumulativa e ammaliante. La capacità delle IA di offrire soluzioni a portata di mano e senza alcuna fatica ha un potere seducente irresistibile. Ma ha un prezzo: il rischio di addentrarsi sempre più entro una relazione uomo-macchina in cui il risultato giunge all’uomo in una modalità oscura, come acquisizione passiva e non trasparente. Non possiamo rinunciare alla caratteristica che ci contraddistingue da tutti gli altri esseri viventi e dalle macchine che agiscono solo in modo intelligente: la nostra capacità di rispondere delle conseguenze delle nostre azioni. Siamo gli unici capaci di responsabilità di fronte al cosmo e alla storia, anche nei confronti delle future generazioni.
La questione etica appare ineludibile, ma va correttamente intesa. Non si tratta di porre limiti alla libertà ponendo a priori dei paletti alla ricerca. Si tratta invece di saper gestire l’innovazione. Si tratta di capire cosa vogliamo raggiungere e perché e come vogliamo farlo. Dobbiamo comprendere la direzione del viaggio intrapreso in cui le macchine non sono più solo inseparabili compagne di viaggio, ma attori con noi della trasformazione. In tale cammino, dobbiamo anche comprendere cosa vogliamo custodire dell’umano che è in noi e cosa, invece, siamo disposti a rischiare. Il processo solleva sfide concrete.
In fin dei conti: chi si affida a chi? Chi si adatterà a chi? E in che misura? Non è casuale che frequentando internet sempre più ci venga chiesto regolarmente di dimostrare che non siamo robot! Dobbiamo soprattutto fare ogni sforzo per essere in grado di immaginare come sarà il futuro e quali esigenze di adattamento saranno poste dall’IA e, più in generale dal digitale, ai loro utenti umani. Ciò può aiutarci ad escogitare soluzioni tecnologiche capaci di diminuire i costi antropologici che si profilano e accrescerne i benefici anche ambientali. Il futuro è già iniziato, plasmato dal passato, ma non è del tutto determinato, perché l’eredità del passato può essere indirizzata in una direzione diversa. Molto dipenderà anche dalla nostra capacità di negoziare le derivanti questioni etiche, giuridiche e sociali, facilitando soluzioni ed evitando, o mitigando, gli aspetti negativi. In ultima analisi la sfida che ci attende è la governance del digitale. Dopotutto è un segno di intelligenza far lavorare in modo intelligente e bene la macchina per noi.
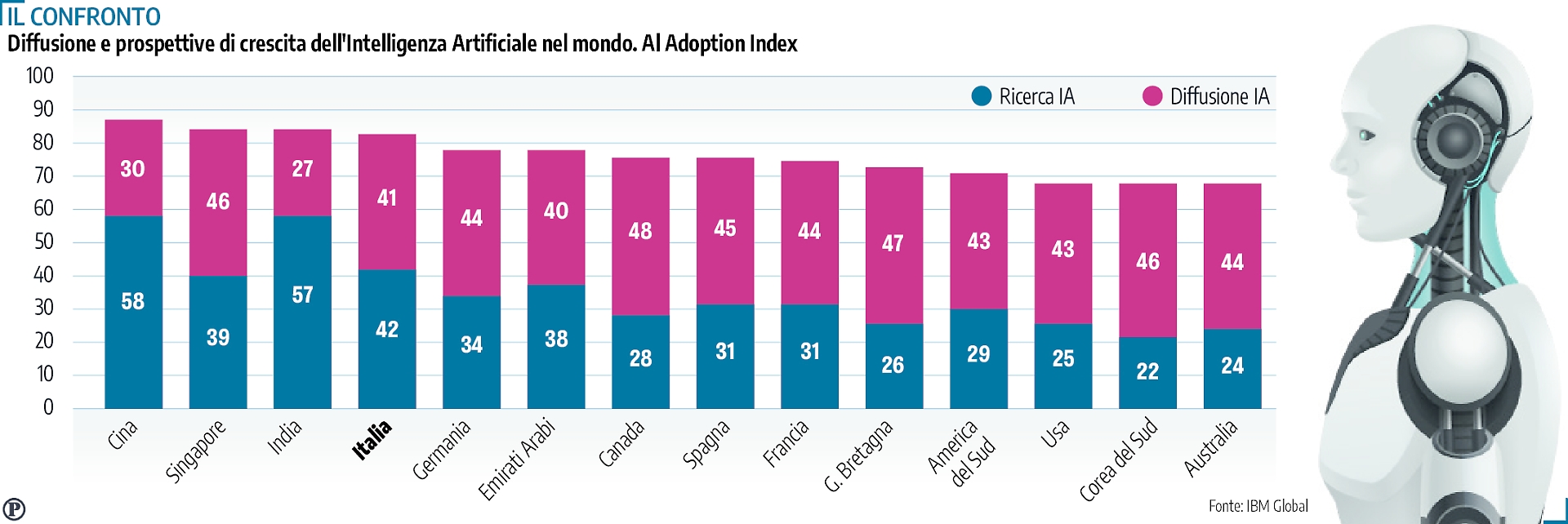
S.E.C. Spa – Divisione Commerciale Publia : P.IVA 00111740197
Via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona : Via Cavour, 53 - 26013 Crema : Via Pozzi, 13 - 26041 Casalmaggiore